I risultati di uno studio dell’Unical, in collaborazione con l’Universidad Nacional Autónoma de México e l’Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, condotto su rocce vulcaniche della Sierra de las Navajas
 |
 |
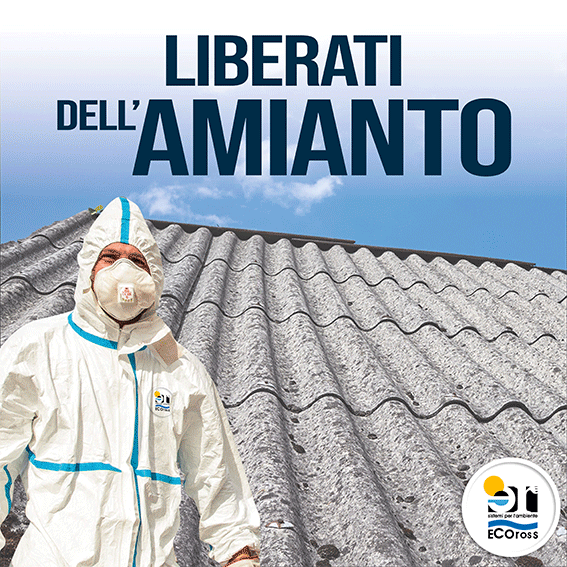 |

Grazie a una serie di raffinate analisi, svolte presso i laboratori del Centro di Microscopia e Microanalisi (CM2) e la stazione sperimentale μTomo dell’Infrastruttura di ricerca STAR dell’Università della Calabria, è stato possibile mappare la tessitura delle ossidiane della Sierra de las Navajas, il complesso vulcanico dello stato di Hidalgo nel Messico Centrale, e stabilire come questa ne influenza alcune importanti caratteristiche macroscopiche.
L’ossidiana è una roccia vulcanica vetrosa che si forma in seguito al brusco raffreddamento di un magma ricco in silice e molto viscoso durante eruzioni effusive o esplosive. La maggior parte di questi vetri vulcanici appare macroscopicamente nera e lucente ma non è raro imbattersi in campioni dalle caratteristiche cromatiche più varie. Alcune delle ossidiane prodotte nella storia eruttiva della Sierra de las Navajas, ad esempio, presentano un verde più o meno intenso e dai riflessi dorati, a volte distribuito in maniera omogenea, altre in bande di intensità differente.
Come riporta lo studio recentemente pubblicato sulla rivista Minerals, queste differenze non sono legate alla composizione chimica dei campioni. Le misure effettuate per mezzo della microsonda elettronica (EPMA) del CM2 hanno suggerito che la colorazione verde potrebbe dipendere da un contenuto in Ferro (in particolare lo ione ferroso) superiore a quello delle più comuni ossidiane nere ma, allo stesso tempo, hanno mostrato come aree cromaticamente differenti del medesimo campione – e campioni tra loro cromaticamente differenti – presentano pressoché la medesima composizione chimica.
La ragione di ciò va dunque ricercata altrove e cioè nella particolare tessitura delle ossidiane, caratterizzata dalla presenza di piccole bolle (le “vescicole”) che si formano quando il gas, in fase di solidificazione, rimane intrappolato nel magma. Il microscopio elettronico a scansione (SEM) del CM2 e le analisi microtomografiche a raggi X condotte presso lo STAR Lab, hanno permesso di ricostruirne forma, dimensioni e distribuzione, rispettivamente sulla superficie e all’interno dei campioni.
Le vescicole, lunghe da poche decine a qualche centinaio di micrometri (più o meno quanto è spesso un capello umano), possono essere tondeggianti o schiacciate e distribuirsi sia in maniera casuale sia lungo direzioni preferenziali. Le zone superficiali in cui ce n’è in abbondanza appaiono di un verde più chiaro, mentre sulle aree non vescicolate o con poche vescicole distribuite casualmente il colore è più scuro. L’aspetto striato di alcuni campioni riflette invece la loro distribuzione in bande in cui sono diversamente orientate mentre il medesimo campione appare molto scuro sulle superfici ortogonali alla direzione di allungamento delle vescicole e più chiaro sulle quelle parallele ad essa.
Ad eccezione di quelli molto scuri, tutti i campioni mostrano un caratteristico riflesso dorato. Anche in questo caso, la vescicolazione gioca un ruolo preminente. L’alta concentrazione di vescicole “grandi” disperde la luce in modo omogeneo in tutte le direzioni e conferisce un aspetto uniforme. Più la concentrazione diminuisce, più la tonalità varia al variare dell’angolo della luce incidente. A bassissime concentrazioni, l’ossidiana diviene scura e priva di riflessi.
La presenza di vescicole influenza anche le proprietà meccaniche: se sono abbondanti, piatte e orientate su piani preferenziali, la frattura del vetro avviene lungo superfici piatte piuttosto che curve (la tipica frattura delle ossidiane scure è invece concoide).
L’uso delle ossidiane nelle popolazioni antiche è dipeso dalle caratteristiche fisiche e cromatiche che lo studio del team multidisciplinare formato dai ricercatori dell’Università della Calabria, dell’Università Nazionale Autonoma del Messico e dell’Istituto Nazionale di Antropologia e Storia del Messico, ha messo in relazione con la loro struttura microscopica: la varietà scura, scarsamente vescicolata, è stata preferita per le armi e gli utensili da taglio mentre per la realizzazione di oggetti rituali e gioielli, è stata utilizzata principalmente quella vescicolata, dal colore verde più brillante e dai riflessi dorati. Approfondendo lo studio della vescicolarità si potranno in futuro ottenere preziose informazioni che permetteranno di completare la ricostruzione della storia pre e post-eruttiva delle ossidiane, a partire dal processo di formazione fino alla loro lenta devetrificazione.
Fonte: Infrastruttura di Ricerca STAR





